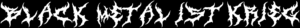C’era molta attesa per l’uscita di questa nuova fatica targata Uada, un’attesa alimentata dai buoni responsi ottenuti dal disco di debutto e dall’ancor migliore “Cult Of A Dying Sun”, lavori che nel breve volgere di pochi anni hanno lanciato la band di Portland nell’Olimpo della musica estrema internazionale, raccogliendo i favori della critica specializzata e di gran parte del pubblico, non senza qualche mugugno di disapprovazione (come, del resto, sempre accade). “Djinn” non farà altro che aumentare il polverone e alimentare le divisioni tra chi ritiene gli Uada un ottimo gruppo melodic black metal (anzi la next big thing del black metal a stelle e strisce) e chi in fondo li ha sempre considerati nient’altro che la brutta copia di Dissection e Mgła, con la furbizia di intuire da che parte tira il vento e di far uscire i dischi giusti al momento giusto, aggravata da qualche evitabile sparata social (non ultima la sterile polemica nei confronti di Marylin Manson). Non è quindi semplice dare un giudizio critico per quanto possibile oggettivo su questo nuovo lavoro dell’ensemble statunitense, sul quale cercheremo comunque di esprimere la nostra opinione senza peli sulla lingua, dicendo fin da subito che, come il precedente disco ci aveva convinto, quest’ultimo ha rappresentato invece in gran parte una delusione. Il perché è presto detto: ascoltando questo terzo studio album, che avrebbe dovuto essere quello dell’ipotetica consacrazione, l’impressione che si ha è quella di una band con le idee poco chiare, tanto da chiedersi quale sia il suo scopo e a quale pubblico effettivamente voglia rivolgersi. Dopo vari ascolti “Djinn” ci sembra una miscela confusa di gothic, doom, progressive e shoegaze, che non riesce a prendere una direzione precisa (con l’intento implicito di piacere a molti, finendo invece per scontentare un po’ tutti, sia i puristi del black sia chi cerca sonorità più vellutate) e se la band intendeva costruire un sound più personale, a nostro giudizio lo scopo non è stato raggiunto. Intendiamoci, di black metal su questo disco ce n’è ma sembra tutto molto annacquato, tra riff innocui a malapena distorti, blast beats poco incisivi e spesso soffocati, cambi di tempo tanto insistiti quanto poco efficaci, canzoni immotivatamente troppo lunghe ed una produzione assolutamente non adeguata (con il suono della batteria troppo ovattato e decisamente sovrastato dalle chitarre), che evidenzia le carenze di una prestazione vocale che fa costante ricorso a filtri ed effetti, azzerando ogni spontaneità espressiva.

La cosa che fa più incazzare è che i brani iniziano quasi tutti nel modo migliore, con una loro personalità, ma poi si perdono in rivoli di lungaggini e ripetizioni. L’opener, che da mesi circola in rete, è forse il pezzo migliore: parte con il più classico dei mood post punk, con tendenze darkeggianti anni ottanta, per poi tornare su sentieri più consoni al metal, con riff davvero ariosi e melodici; se non fosse per la parte finale del pezzo, dove uno stacco decisamente elementare funge da preludio al bel solo di chitarra. Si prosegue con “The Great Mirage”: un’introduzione epica lascia esplodere un riff devastante che ricorda i Dissection (ma dai?) ma il brano si dissolve nel giro di pochi minuti in un saliscendi, tra sferzate blast e parti vocali al limite del narrato, con continui rallentamenti che lasciano interdetti tanto sembrano forzati. “No Place Here”, secondo estratto dal disco, inizia come una tempesta ghiacciata che ci trasporta in lande nord europee: un incipt davvero pazzesco come sinora tutti i pezzi ci hanno regalato ma cosa non quadra? Al netto del forzato rallentamento dopo il primo minuto, questa volta pure le linee vocali risultano piacevoli, nonostante le vocals siano più artefatte di quelle di James Labrie negli ultimi studio album, ma cosa fa la band per giustificare una durata di quasi quattordici minuti? Semplice, decide di inserire parti atmosferiche un po’ a caso nel mezzo e consegnare gli ultimi quattro minuti della canzone a una voce narrante che non farà altro che farvi skippare. Un vero peccato, perché se la durata si fosse assestata sui sei minuti, staremmo parlando di un grande pezzo, così come la successiva “In Absence Of Matter”: grandioso inizio in blast e tremolo, con il binomio ariosità ed epicità sugli scudi, che per quasi dieci minuti, questa volta, riesce a tenere l’ascoltatore sulla corda senza eccessivi cali di tensione, a parte qualche riff che sembra inserito in maniera forzata come se la band volesse dirci “lo sappiamo fare”.

Le battute finali sono affidate a “Forestless”, un brano atipico e non convenzionale, che evidenzia effettivamente la volontà della band di esplorare sonorità nuove, grazie a un inizio al limite del progressive, piacevole nella sua semplicità ma immediatamente violentato da un attacco di netta matrice black in maniera alquanto sgraziata. Con “Between Two Worlds” si chiude questo lavoro controverso come lo si era aperto: dopo un’intro tribale, parte un riff che riprende quello dell’opener, con sonorità che strizzano l’occhio allo shoegaze britannico e rimembranze gothic-rock, per poi, nuovamente, abbandonare questo mood e ributtarsi in una sfuriata di tremolo e blast, che in questo caso sembra almeno più ragionata; o, perlomeno, la band riesce qui ad amalgamare meglio lo spirito rockeggiante a tinte goth con l’anima melodic black della song. “Djinn” è questo: un disco che, se fosse durato venti minuti in meno, al netto di quei riff infilati lì per il mero gusto di sembrare più “alternativi” o “tecnici”, avrebbe avuto tutto un altro impatto. A prodotto finito, rimane un disco ibrido senza una direzione, che farà storcere il naso a molti ma che probabilmente in tanti al contrario apprezzeranno; un disco che negli intenti della band americana (che ha sicuramente un notevole bagaglio tecnico) vorrebbe essere di rottura e prendere più o meno consapevolmente le distanze da una scena black troppo identica a sé stessa, senza però centrare l’obiettivo, se non in alcuni momenti, finendo per tracimare in maniera del tutto ingiustificata. Che sia il classico lavoro di transizione?